
Chi siamo Comunità Italia Merid. Missioni del Pime Martiri del Pime Adozioni e progetti Riviste Links
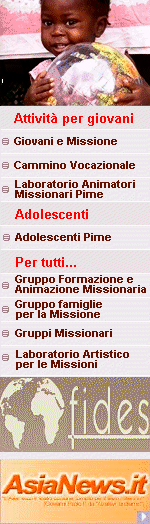
![]()
|
Padre fabrizio (missionario del pime in bangladesh) appunti di viaggio Dinajpur - P.Fabrizio Calegari Rubel Alle iscrizioni per il nuovo
anno scolastico, per i “cuccioli” di classe sesta si
presentano 46 bambini intorno ai 10-12 anni. Procediamo ad
un esame su alcune materie scolastiche per darci modo di
capire un poco il loro livello di preparazione, ma
soprattutto per avere un appiglio a cui aggrapparci per
giustificare quelli che manderemo a casa. Quando abbiamo i
risultati raduno tutti e comunico i nomi di quelli che
resteranno. La maggior parte non ha passato l’esame, ma li
pigliamo lo stesso: avranno un anno per crescere nelle loro
capacità. Li vedo tesi e lo so: tutti sono venuti qui con
la speranza di restare. Tornare a casa vorrà dire per tanti
non poter continuare la scuola. Non è giusto, mi dico. D’altra
parte più di venticinque non posso prenderne. Sono già
tanti. Ad uno ad uno si alzano quelli promossi, mentre gli
altri restano seduti, immagine simbolica che mi intristisce. Uscendo, Rubel mi corre di fianco. Lo conosco da quando aveva 6 anni e praticamente è rimasto alto uguale. Come allora ha sempre quell’allegria e quel sorriso contagioso che mi mettono istintivamente di buonumore. “Padre!” – mi dice agitato e felice – “Avevo una paura matta di non passare!”. “Invece ce l’hai fatta, hai visto?” – gli faccio dandogli uno scapaccione affettuoso. “Sì, però senta qua! – dice Rubel prendendomi la mano e portandosela all’altezza del cuore. Non c’è bisogno dello stetoscopio: dentro il petto da passerotto sento il cuore che pare voglia schizzare fuori tanto batte forte. Un anno nuovo Si ricomincia. Avverto la gioia profonda e la voglia di rimettermi in gioco con i ragazzi. Ho un po’ di idee per le proposte formative di quest’anno. Una è andata in porto proprio in questi giorni e ne sono soddisfatto. Suor Rina – una suora bengalese che ha studiato psicologia in Italia – mi ha assicurato un paio di incontri mensili per le classi dei più grandi. Darà la possibilità ai ragazzi di conoscere meglio se stessi e a me quella di conoscere meglio i ragazzi. L’altro ieri abbiamo fatto la festa di benvenuto per i nuovi 36 arrivati: canti, danze, scenette, dolci e… lavanda dei piedi. Come lo scorso anno ho voluto lavare i piedi a tutti i nuovi, così come la gente usa fare nei villaggi quando arriva un ospite. Prima si versa l’acqua fino al ginocchio, poi si asciuga e infine con l’olio di colza si unge e massaggia. Lo trovo un gesto bellissimo, molto denso, pieno di accoglienza e di attenzione per l’altro. Oltre al fatto che rimanda dritto-dritto al Vangelo. E’ un momento che vivo proprio con la consapevolezza di essere qui solo a servizio dei ragazzi: “Sto in mezzo a voi come colui che serve” (Lc 22,27). Mentre ungo i piedi di Paulus e l’odore pungente dell’olio di colza m’impregna le mani, vedo una cicatrice che porta sullo stinco: “Si ricorda? – mi dice Paulus – Me l’ha curata lei.” Ci metto un po’ ma poi ci arrivo: una caduta giocando a pallone e brutto taglio curato con punti adesivi e mercurio cromo. Roba di cinque anni fa. Mi piace questa cosa. Dei miei ragazzi conosco anche la storia dei piedi. Mica poco. I migliori Consegno le borse di studio a dodici ragazzi che si sono distinti lo scorso anno per risultato scolastico e impegno nell’ostello: scuola, vitto e alloggio saranno totalmente gratuiti per un anno. Con il computer ho preparato un diploma con il nome di ciascuno, così che il premio sia anche visibile. Nel riceverlo, qualcuno è imbarazzato come se stesse rubando, qualche altro quasi piange. Io sono orgoglioso per loro. Soprattutto perché i migliori studenti della scuola – che conta centinaia di ragazzi, in maggioranza musulmani – sono i miei ragazzi. Hanno preso quasi tutte le migliori posizioni per ogni classe. Alla faccia del razzismo bengalese che vuole i tribali inferiori e meno brillanti. Eccoli qui i tribali: dategli una possibilità e, almeno a scuola, non sono secondi a nessuno. Ma i primi a non crederci sono i ragazzi stessi, tanto è forte il senso di inferiorità. Ecco perché queste borse di studio sono uno stimolo e un rinforzo positivo enorme. “Avete visto?” – domando ai ragazzi alla fine. “E allora, chi sono i migliori?”. Silenzio. “Chi sono i migliori?” – ribadisco alzando la voce. “Noi” – risponde qualcuno debolmente. “Chi sono i migliori???” – richiedo gridando e portando una mano all’orecchio, come per sentire meglio le loro risposte. “NOI!” – gridano finalmente tutti quanti. E rimaniamo così a guardarci, ridendo e battendoci le mani. Polas Mentre guardo i ragazzi che giocano a cricket, Polas, 19 anni, mi si siede accanto, all’ombra di una pianta di mogano. E’ in classe decima, nel gruppo dei più grandi. “La sa una cosa, padre?” – dice Polas venendo subito al dunque. “Da quando abbiamo cominciato a vivere ogni mese una frase di Vangelo, qui non è più come prima!”. “In che senso, scusa?” – faccio io che di cambiamenti così radicali non ne ho visti. “Lei sa che qui tra noi ci sono molte etnie diverse. Prima i litigi e i contrasti per questa ragione erano moltissimi. Quasi ogni giorno, si può dire. Adesso non è più così. E io sono convinto che è proprio grazie alle parole proposte del Vangelo”. Sono sorpreso a metà. Da una parte lo sono perché dove non ti aspetti o non vedi miglioramenti a volte altri li vedono e li conoscono. Quante volte è capitato! Dall’altra invece non mi meraviglia, perché sono convinto che il Vangelo vissuto cambia la vita, le abitudini, le tendenze e anche le culture. E’ il Signore Gesù che opera, ed è Lui che i ragazzi incontrano, vivendo le sue parole. La casa di Shumon Approfitto di qualche giorno di vacanza per andare a trovare qualcuno dei ragazzi nei loro villaggi. E’ sempre una bella occasione per imparare a conoscerli meglio. Vedere dove abitano, incontrare i loro genitori, spesso rivela lati nascosti ma importanti della loro storia e del loro carattere. E poi è bello anche solo stare insieme al di fuori del solito ambiente. Shumon vive con due sorelle e la mamma, vedova da tanti anni. Sono stati battezzati da poco, insieme al resto del villaggio, uno dei più miserabili della parrocchia. Tutti e tre i figli sono studenti nei nostri ostelli, prima nelle elementari e ora alle superiori. Non avrebbero avuto altrimenti modo di andare a scuola: la mamma si arrabatta come può, a volte anche in modo non proprio lecito. Non è un mistero che la donna abbia più volte fabbricato vino di palma da vendere ai musulmani, la cui presenza non è mai gradita nel villaggio, specie sotto i fumi dell’alcool. Condannarla sarebbe facile. Di fatto le è stato chiesto espressamente di abbandonare questa pratica se voleva ricevere il Battesimo. Poi guardo la loro abitazione e capisco ogni cosa: una casetta di fango le cui pareti paiono stare su con lo sputo, il tetto di paglia che non reggerà alle prossime piogge, una stanza e un letto solo che deve bastare per quattro quando i ragazzi sono a casa, pochi stracci per vestiti appesi su una lista di legno. Difficile immaginare una miseria maggiore. Eppure i ragazzi sono cresciuti che sono uno splendore. Shumittra, la maggiore, ha ormai 19 anni. Da tempo la mantengo negli studi, perché lo merita e perché un villaggio non ha speranza di riscatto se non nell’educazione dei figli. Shumon è il classico adolescente formato bengalese: in pochi mesi è cresciuto in modo pazzesco, sviluppandosi per il lungo e mettendo in evidenza solo le ossa. Prendendolo in giro lo chiamo “shupari”, come la palmetta di betel che cresce alta, dritta e magra. E lui ride, mostrando tutti i denti bianchissimi, con un sorriso da bravo ragazzo. La mamma mi siede vicino sul bordo del letto, di fianco ai cuscini sudici. Mi mostra il certificato della borsa di studio che a gennaio ho consegnato anche a Shumon. E’ evidente che ne è orgogliosa. Non si tratta solo del fatto economico. C’è molto di più in quel pezzo di carta. Una mamma lo sa. Shumon se lo è guadagnato con un risultato scolastico brillante e un’ottimo comportamento nell’ostello. Dare un premio così a ragazzi come lui riempie di gioia. Mentre Shumittra di fuori si sta prodigando per prepararmi un tè, la madre mi fa capire che c’è qualcosa di cui vuole parlarmi. L’angoscia traspare palese dal suo viso di donna ancora giovane ma invecchiato dalle fatiche, logorato dalla miseria. Indossa un sari liso e sporco e ha i capelli raccolti in qualche modo. In Bangladesh, le vedove ancora oggi soffrono una condizione di emarginazione e degrado che non è differente da quella dei tempi di Gesù. Mi racconta che il padrone del terreno sul quale c’è la loro “casa” vuole venderlo e quindi le ha intimato di andarsene. Tempo per sbaraccare: un mese. Finisce il racconto e non può trattenere un rivolo di lacrime che scivola via sulle guance sciupate. Gli occhi sono due pozzi di rassegnazione. Le prendo una mano, anche per destarmi da un magone che sta prendendo anche me, sarà che sto invecchiando. Shumittra entra con il tè, versato in un bicchiere d’acciaio. Sorride debolmente guardandomi e capisce l’argomento del colloquio. Mi offre anche qualche biscotto che io giro subito alla mamma. Il tè è pessimo, fatto al modo tribale, col sale e lo zucchero insieme. Però non lo do a vedere, ne trangugio qualche sorsata facendo attenzione a non ustionarmi la lingua e vigliaccamente faccio i miei complimenti a Shumittra. Lei si schermisce ridendo imbarazzata. Mi viene in mente che proprio qualche giorno prima ho sentito che non lontano da qui, in un altro villaggio, la Diocesi sta offrendo delle casette in muratura ad alcune famiglie cristiane che si stanno trasferendo lì. Sono certo che ce ne sarà una anche per la famiglia di Shumon. Mentre comunico a tutti questa idea, mi guardano come se parlassi da un altro pianeta. Garantisco che la cosa è possibile, che mi darò da fare. Stavolta è la mamma a prendermi la mano. Cerca di baciarla ma istintivamente la ritraggo perché mi mette a disagio: non sono il salvatore della patria. “Una casa in muratura!” – dice trasognata la donna. “Non ci sarà più da preoccuparsi che i muri crollino durante la stagione delle piogge…”. Shumon è accoccolato in un angolo della stanzetta. Nella penombra vedo che sorride. Pettegolezzi Prendo un risciò per andare in città a fare compere. L’uomo che mi porta e pigia di lena sui pedali, ad un tratto si volta e sorridendo affabile mi chiede: “Come va, padre, tutto bene?”. Lo guardo interdetto. Sono certo di non conoscerlo ma, evidentemente, lui conosce me. Dai tratti somatici non mi pare cristiano, però per conferma glielo chiedo. “No padre, sono musulmano!” – mi dice. “E allora come fa a sapere chi sono?” – chiedo io che adesso sono curioso di sapere. “Ma qui la conoscono tutti! Lei lavora all’ostello con i ragazzi, vero?”. Faccio di sì con la testa, anche se continuo a non capire. “Vede? Da quando lei lavora qui, sono tutti contenti!” – mi dice voltandosi pericolosamente il mio nocchiero, che guarda me e non la strada. Tutti? Tutti chi??? “I ragazzi!” – mi fa lui come se fossi l’unico stupido a non saperlo. Questa poi. Per la serie: “Il paese è piccolo e la gente mormora”. Non so se l’amico musulmano, pedalando, si sia accorto della differenza di carico. Dopo le sue parole sono certo di essere aumentato di peso. Raccontaci Papa Wojtyla Subito dopo la sua morte i ragazzi mi hanno chiesto del Papa, di raccontare chi era, cosa aveva fatto. Loro che si e no lo hanno visto in foto, qualche volta. Ho preparato un album di foto scaricate da internet e mi sono accorto che sfogliarlo era come sfogliare la mia vita. Ho messo anche la mia prima foto scattata con lui: anno 1983, udienza del mercoledì in piazza S. Pietro, la sua mano sinistra sulla mia guancia, la destra stretta tra le mie. Raccontando, mi sono ritrovato a pensare a Giovanni Paolo II con un affetto che è sfociato presto nella commozione. Difficile parlare mentre si piange e ci si sforza di non farlo. E’ che ci sono cresciuto con questo papa. Molti come me si sono trovati in compagnia di Giovanni Paolo II prima nell’adolescenza, poi nella giovinezza, infine nella maturità. Forse per questo, nonostante siano passati un po’ di giorni e la piena dell’ emozione si sia depositata, ugualmente provo un senso di orfanezza che fatica ad andarsene. Allo stesso tempo però mi accorgo di ritrovare in me la gioia di saperlo accanto come mai prima. Fin da subito, dopo la sua morte, ho cominciato a pregarlo e ad affidarmi a lui, come non avrei potuto fare prima. Non c’è più bisogno di chiedere udienza o di aspettare raduni. Giovanni Paolo non se n'è andato. E' qui, vivissimo. Mi pare un bel vantaggio. Mentre mostravo ai ragazzi le immagini registrate alla televisione del funerale, guardavo la folla immensa che stipava Roma e tornavo a chiedermi cosa l’avesse spinta a questa “follia” del riversarsi in massa laggiù. Immagino che sociologi e psicologi abbiano versato fiumi di parole per spiegarla. Ma se penso a quello che ha affascinato me di Giovanni Paolo II, credo di trovare, forse, una risposta parziale ma possibile. Papa Wojtyla è stato un uomo vero, anzitutto. Vero e libero, fino in fondo. Non ha mai smesso di mostrare quello che era, sia negli anni belli, quando fisicamente si imponeva, sia in quelli dello strazio della malattia e del corpo rattrappito. Lo abbiamo visto sciare e affrontare viaggi massacranti ma anche impossibilitato a camminare, perdere la bava, senza mai nascondersi; ridere piegato in due per un numero di clown e rapito in preghiera davanti al Santissimo; affascinare folle di giovani con catechesi esigenti e senza sconti ma anche, alla fine, restare senza parola e impotente. Un uomo vero, dunque, e un uomo di Dio. Un mistico, hanno detto molti. Lo credo anch’io. Ci ha ridato la fierezza di dirci cristiani, senza paura e senza timidezze: non con arroganza ma per la gioia consapevole di avere incontrato il Risorto. E la gioia è contagiosa, come la santità. Attira. Non sta ferma, si propone e annuncia. Non a caso la missione è una delle chiavi di lettura fondamentali del suo pontificato. La gente lui è andata a cercarla nelle loro case, non è stato ad aspettarla in S. Pietro. L’avessero capito anche tanti preti. L’ultima grande catechesi sono stati gli ultimi giorni di vita. In fondo credo che in tanti abbiamo sperato, inconsciamente, di vederlo morire così. Volevamo la conferma, altro che dimissioni. Volevamo che dopo averci insegnato a vivere, ci insegnasse anche come morire. Se la folla è accorsa è perché sapeva che incontrando un uomo vero incontrava anche un vero uomo di Dio. Un santo, hanno gridato al funerale. Anche qui in Bangladesh, nel nostro piccolo, la morte del papa ha avuto una grande eco. Prime pagine dei giornali, molti articoli positivi, servizi al telegiornale. La gente ne parlava anche al mercato. Me lo raccontava un cristiano, orgoglioso: aveva ascoltato i musulmani che ne parlavano ammirati, perché vedendo la folla in televisione, commossa, in preghiera, in fila tranquilla e senza disordini, hanno semplicemente dedotto: “Quest’uomo è un santo”. Per la nostra piccola comunità cristiana questa testimonianza è un credito prezioso da non sciupare, che potrebbe tradursi in maggiore rispetto e forse amicizia. Un altro dono di Giovanni Paolo. P.Fabrizio Calegari
FONTE: MISSION BLOG (PIME - Direzione Generale)
|
